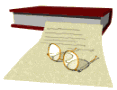Articolo da CTXT
Questo articolo è stato tradotto automaticamente. La traduzione rende il senso dell’articolo, tuttavia consigliamo di leggere il testo originale su CTXT
C'è un momento in Cover-Up, il
documentario su Seymour Hersh presentato di recente su Netflix, che illustra perfettamente il metodo di lavoro del
leggendario giornalista investigativo americano. Accade quando Hersh spiega a Laura Poitras e Mark Obenhaus, i registi, come ha rintracciato il soldato al centro del massacro di Mo Lai, uno dei più grandi scandali della guerra del Vietnam, denunciato da Hersh nel 1969.
Hersh seguiva il Pentagono da un po' di tempo. Ma invece di stare insieme agli altri giornalisti e riferire ciò che i superiori si degnavano di dire loro nelle loro conferenze stampa quotidiane, Hersh andava alla mensa, dove stringeva amicizia con funzionari e ufficiali. Un giorno, ricevette una chiamata da uno sconosciuto che gli raccontò una voce: un soldato era impazzito in Vietnam, uccidendo molte persone. Poco dopo, Hersh incontrò un amico colonnello in un corridoio del Pentagono, qualcuno che non vedeva da anni, che era appena stato promosso non solo a generale, ma anche nominato capo di stato maggiore del comandante delle forze statunitensi in Vietnam, William Westmoreland. Scherzando con l'amico, Hersh gli chiese a bruciapelo: "Ehi, cosa sai di quel tizio che ha sterminato un intero villaggio?". "Senti, Sy", rispose l'altro, "spero che il diavolo in persona si prenda quel Calley".
Così, senza rendersene conto, il generale non solo confermò la voce, ma fornì anche un indizio cruciale: il cognome del soldato. Questo permise a Hersh di intraprendere una ricerca azzardata – inclusa una visita allo studio di un avvocato, dove riuscì a trascrivere una pagina di un fascicolo che l'avvocato aveva inavvertitamente lasciato esposto mentre discutevano di qualcos'altro – che alla fine lo portò a una base militare, dove riuscì a intervistare il soldato. Passo dopo passo, scoprì che il massacro di Mỹ Lai non era un'atrocità isolata o individuale, ma si inquadrava piuttosto in un modello di violenza militare contro i civili.
La combinazione di audacia, tenacia e ingegno che lo portò a questo scoop avrebbe definito l'intera carriera di Sy Hersh, l' outsider per eccellenza . Nacque nel 1937, durante la Grande Depressione, in una famiglia ebrea in un quartiere a maggioranza nera nel South Side di Chicago. Dopo la morte improvvisa del padre, dovette rilevare l'attività di famiglia, una lavanderia a secco. Fu un incontro casuale – un professore che riconobbe il suo talento – che lo portò all'Università di Chicago, e un altro incontro casuale – un incontro fortuito con qualcuno che lavorava in un giornale – che gli permise di scoprire la sua vocazione come giornalista. Da giovane reporter, gli fu assegnato il compito di seguire la polizia municipale in una città ancora dominata dalla mafia. Si innamorò all'istante della professione; quell'infatuazione dura da oltre 60 anni.
Cover-Up, che combina una retrospettiva della sua carriera con interviste in cui Poitras e Obenhaus non si tirano indietro di fronte a domande scomode, è un omaggio al suo protagonista ottuagenario. Ma è anche il ritratto di un'intera generazione. Infatti, ci permette di intuire i tratti che hanno definito la scuola di giornalismo che Hersh ha contribuito a consolidare e che è riuscita a svelare alcuni dei più grandi scandali politici del XX e XXI secolo, dal Watergate agli eccessi della CIA in America Latina e agli abusi degli Stati Uniti in Iraq.
Sebbene Hersh e i suoi colleghi prosperino grazie alle fughe di notizie, non cadono mai in quello che oggi conosciamo come giornalismo delle fughe di notizie . Le fonti che finiscono per condividere informazioni segrete con il giornalista sono importanti, ma non controllano la narrazione. La fiducia che ripongono nel giornalista si basa, soprattutto, sull'aspettativa che gestisca le informazioni trapelate in modo responsabile e protegga la loro identità a tutti i costi. Infatti, Hersh – che ha impiegato 20 anni per accettare la proposta di Poitras di realizzare un documentario su di lui – si lamenta ripetutamente con la troupe cinematografica, alla quale ha dato accesso a tutti i suoi appunti. Più volte se ne pente e minaccia di gettare la spugna. Quello che stanno facendo, dice, "è un male per la mia gente". È sorprendente che si riferisca alle sue fonti come se fossero suoi parenti.
Quando Poitras gli chiede perché, nel corso degli anni, così tante persone siano state disposte a condividere con lui dati sensibili, risponde: "Le persone divulgano informazioni per molti motivi diversi. Offro loro un servizio. Se la fuga di notizie è valida, mi impegno a fondo". I divulgatori non sempre condividono gli obiettivi di Hersh – scoprire gli abusi – ma molti decidono di farlo per motivi etici.
Una seconda caratteristica sorprendente è che i giornalisti della generazione di Hersh tendono a operare da soli. Diffidano dei collettivi e delle istituzioni, compresi gli stessi organi di stampa per cui lavorano. Di solito non sono colleghi con cui è facile lavorare; non sono certo dei giocatori di squadra . Vanno controcorrente, sono piuttosto testardi e si arrabbiano facilmente. Ripongono molta più fiducia nel loro intuito che nel giudizio dei superiori o nei protocolli ufficiali. D'altro canto, questo modus operandi solitario conferisce loro anche un umanesimo e una flessibilità che li aiutano a mantenere la loro vasta rete di contatti personali.
In terzo luogo, Hersh e i suoi colleghi non sono stati pignoli riguardo ai media utilizzati per diffondere il loro lavoro. I principali quotidiani e le riviste affermate hanno certamente avuto un ruolo. Ma lo scoop su Mỹ Lai, che gli è valso il Premio Pulitzer, è stato pubblicato da un'agenzia di stampa di seconda categoria perché i media mainstream non hanno voluto prenderlo in considerazione. Hersh ha anche scritto libri, tra cui un resoconto demistificante della presidenza di John F. Kennedy, e ha collaborato a documentari. Da diversi anni scrive per Substack, dove conta duecentomila abbonati.
Considerando tutto ciò, l'orientamento politico di Hersh è stato più difficile da individuare. Richard Nixon lo considerava un pericoloso comunista, per il quale, tuttavia, nutriva un curioso rispetto ("Quel figlio di puttana è un figlio di puttana, ma di solito ha ragione", scherzò il presidente in una conversazione con Kissinger, la cui registrazione è riprodotta da Poitras e Obenhaus). Quando Hersh si dedicò a svelare le atrocità americane in Vietnam, alcuni suggerirono che venisse deportato a Cuba.
Ma sebbene Hersh si identifichi spesso come un "vecchio di sinistra", in realtà opera a partire da un quadro politico molto più basilare: è un patriota americano che, in quanto figlio di immigrati, prende molto sul serio i valori democratici e repubblicani che gli sono stati insegnati nella scuola pubblica ("È la persona più patriottica che conosca", mi ha detto Dan Kaufman, un ex collega). Diffida di ogni forma di potere, a cominciare dal suo stesso governo. Alla fine del documentario, Hersh si commuove quando parla del peso emotivo che comporta coprire episodi di violenza estrema. Poitras gli chiede perché, nonostante tutto, continui a dedicarsi a questo lavoro. "Perché non puoi permettere a un Paese di fare questo e poi lasciarlo guardare dall'altra parte", risponde Hersh. "Non puoi."
La conclusione più importante del documentario, tuttavia, è forse un'altra: il vero giornalismo, quello che racconta storie e cambia il mondo, è umano. In ogni senso. Può sembrare ovvio, ma vale la pena ripeterlo in un momento in cui la minaccia più grande che incombe sulla professione è il parassitismo robotico dell'intelligenza artificiale. Per quanto si dedichino a organizzare e sintetizzare le informazioni, il lavoro di Hersh e del suo team è frutto, da un lato, di valori etici e solidali e, dall'altro, di relazioni interpersonali caratterizzate da fiducia e scetticismo, intuizione e affetto e, spesso, da una fede francamente irrazionale nella possibilità di scoprire e dire la verità.
Che questo giornalismo sia umano – etico, intuitivo, interpersonale – significa anche che è fallibile. L'intuizione non è sempre giusta. Hersh ha la reputazione di essere testardo e irascibile, ma quando Poitras e Obenhaus gli chiedono di alcuni dei suoi lavori più criticati – tra cui la sua copertura compassionevole del governo di Bashar al-Assad, che ha cercato di negare l'uso di armi chimiche – Hersh ammette di essere stato ingannato dal leader siriano. "L'ho visto tre o quattro volte e non pensavo fosse capace di quello che ha fatto", confessa. "Si potrebbe dire che mi sbagliavo. Sbagliavo di grosso". "È un esempio di cosa può succedere quando ci si avvicina troppo al potere?" chiede Poitras. "Assolutamente", risponde Hersh.
Il giornalista è meno contrito per
un articolo del 2023 che sostiene che il
sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico sia opera dei servizi segreti statunitensi. Questa indagine, come altre recenti di Hersh, sembra basarsi su un'unica fonte, cosa che molti nel settore considererebbero eticamente discutibile. "Le critiche sono legittime", dice Hersh, "ma cosa volete che faccia?". "E se la fonte sbagliasse?", chiede Poitras. "Beh, allora mi sbaglio da 20 anni", risponde Hersh imperturbabile. "Perché lavoro con quest'uomo da 20 anni. E alla fine, si è sempre scoperto che quello che mi diceva era vero".
"Anche se non sono d'accordo con tutto ciò che ha fatto, Sy Hersh è uno dei miei eroi", mi dice al telefono David Kaplan, un veterano giornalista americano che ha diretto il Center for Public Integrity (CPI), l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e il Global Investigative Journalism Network (GIJN). "Tutti noi che svolgiamo questo lavoro gli dobbiamo molto. Il suo lavoro segna una pietra miliare in una lunga tradizione americana che ha avuto inizio con i giornalisti scandalistici di inizio secolo : personaggi come Upton Sinclair, Lincoln Steffens e Ida Tarbell", aggiunge Kaplan. “Si tratta di giornalisti che, come Sy, partono da un luogo di indignazione morale. Non è un caso che, quando fu fondata, l'associazione americana dei giornalisti investigativi adottò l'acronimo IRE. Oltre a questo punto di partenza etico, i principi fondamentali della professione rimangono gli stessi. Si tratta di intraprendere indagini sistematiche e a lungo termine che partono da ipotesi e cercano prove concrete per dimostrarle o confutarle.”
"Tuttavia", aggiunge Kaplan, "i giornalisti scandalistici del passato erano lupi solitari, come Hersh. Oggi, i cambiamenti tecnologici e le pressioni politiche hanno reso i modelli
collaborativi i più efficaci: molti di noi lavorano in team investigativi che riuniscono diverse testate giornalistiche e spesso trascendono i confini nazionali. Da un lato, la tecnologia ha creato ulteriore pressione, date le forme di sorveglianza costanti e sempre più invasive a cui i giornalisti sono sottoposti. Dall'altro, le fughe di notizie sono anche molto più facili. Oggi è estremamente difficile mantenere un segreto. Tutti i registri di una banca, ad esempio, stanno in una singola chiavetta USB. E disponiamo di metodi informatici che ci permettono di analizzare i dati su una scala che sarebbe stata inimmaginabile quindici anni fa".
Ma anche Hersh, quel lupo solitario, aveva collaboratori e team di supporto. "Era sempre impaziente e duro, ma nutriva grande rispetto per noi", mi ha detto il giornalista Dan Kaufman, che ha lavorato con lui per diversi anni come fact-checker per la rivista The New Yorker . Questo è stato il periodo in cui Hersh ha denunciato gli abusi nella prigione di Abu Ghraib in
tre articoli consecutivi.
"Ci stimava", ricorda Kaufman, "perché gli importava che rafforzassimo il rigore dei suoi articoli". "Non esiste rapporto più simbiotico di quello tra un giornalista e i suoi fact-checker",
ha affermato Hersh nel 2018 in occasione del lancio di un libro, "perché si basa sulla fiducia: secondo le regole del New Yorker, il fact-checker deve parlare con tutte le mie fonti, non importa quanto segrete siano".
Il suo rapporto con i redattori, d'altra parte, tendeva a essere più teso. "Bisogna capire la pressione che gravava su ogni articolo di Hersh. Dato l'argomento, la rivista era sempre sotto minaccia di azioni legali. Di solito lavorava con due redattori – Amy Sorkin e John Bennett,
un'altra leggenda – e due correttori di bozze. Erano giornate lunghe, con 40 o 50 telefonate da parte di Hersh, tutte molto brevi, impazienti ed emozionate. Ma una volta terminato il lavoro, ci ringraziava per il nostro impegno con grande generosità."
"Come giornalista, ho imparato molto da Sy", afferma Kaufman. "Nel mio lavoro, ho assimilato a fondo il suo mantra personale: farsi da parte per lasciare che la storia si svolga. Una delle cose che ammiro di più in lui è la sua capacità di dare spazio alle voci dei testimoni, che a volte tratta con una certa tenerezza. Un'altra è la sua perenne sfiducia nei confronti delle narrazioni ufficiali e delle élite che le propagano. In questo senso, le sue radici operaie sono cruciali. Quando sa che la narrazione ufficiale che viene propagata è falsa, la prende sul personale. L'indignazione morale che lo guida è genuina e costante, così come il suo patriottismo".
"Non conosco nessun giornalista che persegua le proprie storie con più tenacia", aggiunge Kaufman. "È incredibile che, a 88 anni, scriva almeno un articolo a settimana. E so per certo che lavora ancora con i fact-checker di Substack. Sebbene i pezzi che pubblica lì abbiano meno peso rispetto a una rivista come il New Yorker, lavorare per Substack gli permette di correre più rischi, anche se questo significa che potrebbe sbagliarsi. A questo punto, se lo può permettere. Dopotutto, due dei suoi scoop, il massacro di Mo Lai nel 1969 e il massacro di Abu Ghraib nel 2004, hanno svelato le dimensioni nascoste del potere americano. E così facendo, hanno cambiato il corso della storia".